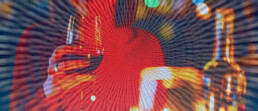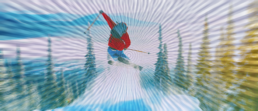STUDI – Vino made in Italy a 7,6 miliardi euro. Veneto, Piemonte e Toscana in Ue 27 dietro solo a Francia e Spagna
Nel 2022, ultimi dodici mesi a giugno, l’export di vini di uve vale 7.565 milioni di euro, registrando nel primo semestre del 2022 un aumento del 13,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nell’Unione europea a 27 l’Italia è seconda esportatrice dietro a Francia con 11.743 milioni di euro, posizionandosi davanti a Spagna con 3.004 milioni, Germania con 1.013 milioni e Portogallo con 921 milioni.
La competitività sui mercati internazionali è supportata dalla qualità vini italiani, con le loro peculiarità e varietà. Secondo la più recente rilevazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al 21 novembre 2022 sono 526 i vini Doc (Denominazione di Origine Controllata, tra i quali spiccano i Docg, Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e Igt (Indicazione Geografica Tipica).
Il made in Italy di vini di uve cresce dal 2010 e, nonostante un calo nel 2020, nel 2022 conferma il massimo storico di 0,4% sul PIL toccato nel 2021, valore identico a quello della Francia e doppio rispetto allo 0,2% della Spagna.
L’analisi sull’export dell’alimentare e bevande, con il focus sul vino made in Italy, è contenuta nell’Elaborazione Flash ‘Un regalo di Natale a valore artigiano. Focus su Artigianato alimentare – 12a edizione’. Qui per scaricarla.
In una classifica ibrida tra le regioni italiane e gli altri 26 paesi dell’Unione, il Veneto si colloca al 3° posto dietro a Francia e Spagna, con 2.709 milioni di euro di export di vino, seguito da Piemonte con 1.249 milioni e Toscana con 1.219 milioni, regioni che sopravanzano Germania con 1.013 milioni, Portogallo con 921 milioni, Trentino-Alto Adige con 612 milioni e Paesi Bassi con 536 milioni.
In chiave regionale la maggior propensione all’export di vini di uve si riscontra in Veneto con una incidenza dell’1,8% sul valore aggiunto regionale, Trentino-Alto Adige con l'1,4%, Toscana con l'1,1% e Piemonte con l'1,0 %, valori almeno due volte la media nazionale dello 0,5%.
Tra le principali regioni, nei primi sei mesi del 2022 il maggiore dinamismo dell'export di vini si registra in Veneto con un aumento del +18,7% seguito da Toscana con +16,5%, una crescita più moderata si registra in Piemonte con +4,6% mentre in Trentino-Alto Adige si registra una flessione dello 0,9%. Tra le altre regioni si registra una dinamica superiore alla media in Friuli-Venezia Giulia con +55,4%, Molise con +50,2%, Marche con +39,4%, Sicilia con +33,0% e Campania con +19,3%, Sardegna con +16,6% e Puglia con +15,9%.
Made in Italy di vini di uve: 1995-2022
Anni 1995-2021, 2022 (ultimi 12 mesi cumulati a giugno); % del PIL con 2022 da previsioni di novembre 2022. Ateco 2007: 11.02 - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Commissione europea
Dinamica del made in Italy di vini di uve per regione
I semestre 2022. Variazione % tendenziale. Ateco 2007: 11.02. Primo gruppo: prime regioni esportatrici (76,8% export totale) - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
STUDI – Economia della montagna, Italia 1° in Ue 27 con 805,6 miliardi di PIL
Tradizionalmente a dicembre si apre la stagione del turismo invernale. Nei mesi invernali di dicembre, gennaio e febbraio si addensano 39,0 milioni di presenze turistiche, il 10,1% del totale annuale. I territori caratterizzati dall’offerta di servizi per l’attività sciistica presentano una più elevata vocazione turistica: il tasso di turisticità più elevato lo riscontriamo in provincia di Bolzano con 63,3 giornate di presenza nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante, seguita da Trento con 33,8 presenze per abitante, Valle d'Aosta con 28,9 presenze per abitante e Veneto con 14,6 presenze per abitante.
Il turismo rappresenta un pilastro chiave dell'economia della montagna, cluster per cui l'Italia è leader in Europa. Secondo la classificazione territoriale europea di Eurostat, l’Italia è il primo paese dell’Unione europea a 27 per PIL realizzato in province montane, territori in cui almeno metà della superficie e/o della popolazione è in aree montane: nel 2019 ammonta a 805,6 miliardi di euro, il 44,9% del totale nazionale, una quota più che doppia rispetto al 20,7% registrato dalla media delle aree montane nell’Ue. Il valore dell’economia italiana della montagna supera i 776,3 miliardi di euro della Spagna (che presenta una quota sul PIL del 62,4%), i 417,5 miliardi della Francia (17,1% del PIL) e i 241,5 miliardi della Germania (7,0% del PIL). l’Italia rappresenta 12,8% sul PIL dell’Ue, ma la sua quota sale al 27,8% del PIL delle aree montane dell’Unione europea.
Nell’economia della montagna, a fronte del 47,8% della popolazione nazionale, si concentra nel 2021 il 51,1% delle presenze turistiche totali ed il 50,7% delle presenze turistiche straniere.
L’analisi che delinea i caratteri della mountain economy è contenuta nel 17° Rapporto annuale ‘Imprese nell’Età del chilowatt-oro’ pubblicato in occasione dell’Assemblea di Confartigianato del 22 novembre 2022. Qui il comunicato stampa sul Rapporto dell’Ufficio Studi e qui i Key data.
In Italia sono 63 le province montane e contano 2.077.826 micro e piccole imprese (MPI) attive con 5.137.434 addetti che sono il 47,3% degli addetti nazionali delle MPI. Nel perimetro delle province che rappresenta l’economia italiana della montagna, le MPI rappresentano il 69,4% degli addetti delle imprese totali di tali province, una quota ampiamente superiore al 63,4% della media nazionale. In particolare, nelle province montane sono 536.282 le imprese artigiane attive con 1.349.075 addetti, pari ad oltre la metà (53,0%) degli addetti dell’artigianato italiano ed al 18,2% degli addetti nazionali, quota superiore al 14,8% della media nazionale.
Nel 2021 l’economia della montagna rappresenta il 44,9% del valore aggiunto nazionale e in chiave settoriale presenta una quota più elevata per il valore aggiunto delle costruzioni (48,8%) e del manifatturiero esteso (48,6%), settori in cui è più alta la vocazione artigiana.
L’alta diffusione dell’artigianato e delle micro e piccole imprese rappresenta un fattore di coesione economica e sociale nelle aree di montagna, come approfondito in una nostra precedente analisi della struttura imprenditoriale realizzata in collaborazione con gli Osservatori MPI di Confartigianato Lombardia e di Confartigianato Emilia Romagna.
Grazie alla diffusa presenza di imprese manifatturiere, l’economia della montagna realizza il 47,2% delle esportazioni nazionali, pari a 232,6 miliardi di euro.
Nei territori dell’economia della montagna si registra una maggiore propensione all’imprenditorialità e una più elevata presenza di lavoro autonomo: nelle province montane, a fronte del 47,3% di occupati totali nel 2021, si concentra il 49,8% degli occupati indipendenti - imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi - che rappresentano il 23,0% degli occupati di tali province, quota superiore di 2,2 punti al 20,8% delle altre province non montane. I dati sulle previsioni della domanda di lavoro delle imprese rilevati da Unioncamere-Anpal indicano che nel trimestre novembre 2022-gennaio 2023 nelle province montane sono previste 553mila entrate di lavoratori, pari al 46,0% di quelle nazionali.
PIL delle aree montane in 14 paesi Ue
Anno 2019. Milioni €. Esclusi: Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e Ungheria - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
STUDI – Servizi alla persona, alto abusivismo (27,6%) e forte ritardo ripresa (-11,7% valore aggiunto). Confartigianato al TG3
L’analisi degli dati dei conti nazionali evidenzia che il comparto che presenta il maggiore ritardo nella ripresa post pandemia è quello centrato sui servizi alle persone: negli ultimi dodici mesi a settembre 2022 il valore aggiunto nelle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la casa e altri servizi rimane dell’11,7% inferiore al livello del 2019, con un calo cumulato di 1,8 miliardi di euro, mentre il totale economia segna un recupero dello 0,8%. In questo cluster dell’economia è più elevata la presenza di indipendenti irregolari, con una quota che arriva al 27,6%, di oltre undici punti più elevata rispetto al 16,0% dei Servizi.
Il fenomeno preoccupante dell’abusivismo, rappresentato dal cosiddetto “mondo parallelo” di oltre 1 milione di indipendenti irregolari, è stato descritto nei giorni scorsi da Guido Radoani, Responsabile Sistema Impresa di Confartigianato, nel servizio 'I fantasmi del fisco' al TG3.
Nell’intervento è stato ricordato che l’abusivismo è un fenomeno virale, e pericolosamente strutturato che espone alla concorrenza sleale di operatori abusivi che si spacciano per imprenditori oltre 700 mila imprese regolari, in particolare nei settori dei servizi quali benessere, autoriparazione, impianti, edilizia, giardinaggio, trasporto persone e merci, comunicazione.
La concorrenza sleale degli abusivi è un fenomeno sottovalutato, mentre grava in modo rilevante sulle casse dello Stato, sulle dinamiche retributive, sulla crescita dimensionale delle imprese, influenzando le politiche di riduzione della pressione fiscale. Serve una intensificazione delle segnalazioni e dei controlli da parte delle autorità competenti, mentre vanno unite le forze del mondo della rappresentanza d’impresa per contrastare il fenomeno, come si è verificato nella lotta alla contraffazione e all’italian sounding.
La campagna e il report di Confartigianato – Nel 2022 Confartigianato ha lanciato la Campagna nazionale di informazione contro l’abusivismo dal titolo ‘Occhio ai furbi! Mettetevi solo in buone mani” e, in parallelo è stata pubblicata una analisi sullo spiazzamento delle attività legali da parte del sommerso, contenuta nell’Elaborazione Flash ‘Key data - Il sommerso e la concorrenza sleale dell’abusivismo: gli indipendenti irregolari’, corredata da una appendice statistica con i dati per regione e provincia delle imprese nei settori più esposti dalla concorrenza sleale dell'abusivismo. Qui, in ‘Studi e ricerche’ per scaricare report e appendice.
Key data – Sommerso e la concorrenza sleale dell’abusivismo
1.003.500 unità indipendenti non regolari
14,4% tasso di irregolarità del lavoro indipendente
+0,7% aumento indipendenti non regolari nell’ultimo anno (2019), a fronte del calo del 2,4% dei dipendenti non regolari
+0,4 punti, l’aumento tasso di irregolarità degli indipendenti in vent’anni
3,2 milioni di occupati non regolari
11,3% peso sul PIL dell’economia non osservata (sommerso + illegale)
37,9% quota del lavoro irregolare sull’economia non osservata
46,4% pressione fiscale reale stimata sull’economia emersa per il 2022, +5,2 punti superiore rispetto al 41,2% di pressione fiscale effettiva
587.523 imprese artigiane nei settori sotto pressione per la concorrenza sleale dell’abusivismo, 82,8% delle 709.959 imprese totali nel perimetro in esame
45,9% dell’artigianato nei settori esposti alla concorrenza sleale del sommerso
Dinamica valore aggiunto nella ripresa post-pandemia e tasso irregolarità indipendenti
2022 (ultimi 4 trimestri al III trimestre 2022), var. % vs 2019, dati grezzi a prezzi costanti, 2019 per tasso irregolarità indipendenti, sezioni L-M-N n.d. - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
STUDI - Italia sale al 1° posto in Ue a 27 per inflazione energetica. Con stretta monetaria, riduzione del deficit e ritardi PNRR rischio stagflazione
Nella seduta del 15 dicembre il Consiglio della Bce ha inasprito la stretta monetaria, con un ulteriore rialzo di 50 punti base i tassi di riferimento, portando l’aumento a 250 punti base da luglio a dicembre. I tassi di interesse aumenteranno ancora, “in misura significativa a un ritmo costante” per garantire un “ritorno tempestivo” dell’inflazione al target del 2%, da cui siamo ancora lontani: secondo i dati definitivi di novembre 2022 pubblicati venerdì scorso, l'inflazione nell'Eurozona scende al 10,1% dal 10,6% di ottobre, mentre in Italia rimane costante al 12,6%.
In un semestre di recessione tecnica - terzo trimestre 2022 e primo trimestre del 2023 con segno negativo della crescita del PIL - la politica monetaria diventa pro-ciclica e sincronizzata con una politica fiscale prudente, finalizzata a garantire una riduzione del debito, come confermato dalla parere della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio dell'Italia pubblicato mercoledì scorso. Come evidenziato nel 22°report Confartigianato presentato il 5 dicembre, la manovra di bilancio varata dal Governo, nel 2023 è espansiva portando l'indebitamento netto dal -3,4% PIL tendenziale (a legislazione costante) al -4,5% PIL programmatico (con effetti della manovra). Persiste, però, un elevato sforzo fiscale, con l’indebitamento netto strutturale, al netto delle misure una tantum e della componente ciclica, che si riduce di 1,3 punti, passando dal -6,1% del PIL nel 2022 al -4,8% del 2023.
Sulla crescita pesano anche i ritardi degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come ha evidenziato una nostra recente analisi. Va ricordato che sulla previsione del Governo di crescita del PIL nel 2023 del +0,6%, 0,3 punti arrivano dalla manovra di bilancio e altri 0,3 punti dall’attuazione del PNRR: senza questi due impulsi l’economia italiana segnerebbe una 'crescita zero', avvicinandosi pericolosamente ad una stagflazione. Uno scenario di recessione e alta inflazione che non si concretizza da 47 anni: fu nel 1975 che il PIL scese del 2,4% a fronte di un tasso di inflazione del 17,0% mentre risultarono più contenuti i tassi di inflazione in altre recessioni (inflazione al +3,0% nel 2012, al +3,3% nel 2008 e al +4,6% nel 1993).
La più elevata inflazione in Italia è alimentata da una crescita dei prezzi dell'energia che non ha confronto in Europa. A novembre i prezzi dei beni energetici salgono del 68,1% (era 71,7% ad ottobre), un ritmo doppio del +34,9% della media dell'Eurozona. Si tratta dell'inflazione energetica più alta di tutta l'Unione europea a 27, dopo il marcato rallentamento registrato nei Paesi Bassi. Nel dettaglio, a novembre l’indice dei prezzi dell'energia elettrica in Italia sale del 174,8% (era 199,0% ad ottobre) a fronte del +39,6% registrato in Eurozona; persiste un ampio divario anche per i prezzi del gas, che in Italia salgono del 96,5% rispetto al 67,0% della media europea. Gli effetti recessivi sui bilanci di famiglie e imprese italiane innescati dal caro bollette sono più intensi rispetto agli altri paesi Ue: se prendiamo in considerazione la media dei primi undici mesi del 2022, l’indice dei prezzi di elettricità, gas e altri combustibili in Italia sale del 81,7% rispetto allo stesso periodo del 2021, in Germania del 33,2% mentre in Francia la crescita si ferma al 18,8%. Secondo le recenti valutazioni dell'Istat, per i consumi energetici dell’abitazione principale le famiglie residenti in Italia hanno sostenuto nel 2020 una spesa complessiva di 36,0 miliardi di euro, di cui l’83,8% è attribuibile al metano (15,6 miliardi di euro) e all’energia elettrica (14,5 miliardi). Seguono la legna da ardere e il pellet con 2,5 miliardi di euro, il GPL (di rete o in bombola/cisterna) con 1,8 miliardi di euro (5% della spesa totale) e il gasolio con 0,8 miliardi (2,3%). Una quota residua di spesa (0,7 miliardi di euro) compete agli impianti centralizzati (per riscaldamento o acqua calda), alimentati a biomasse o ad altra fonte.
Il divergente andamento dei prezzi delle commodities energetiche pone un problema di competitività delle economia italiana. Se prendiamo a riferimento l’aggiornamento dell’analisi di Bruegel curata da Giovanni Sgaravatti, Simone Tagliapietra e Georg Zachmann gli interventi contro il caro energia in Germania ammontano al 7,1% del PIL, 2 punti sopra al 5,1% dell’Italia, nonostante l’inflazione energetica tedesca sia di 28 punti inferiore a quella italiana (a novembre in Germania è pari al 40,1% a fronte del 68,1% in Italia). L’intensità degli interventi statali tende a correlarsi con la pressione dei prezzi energetici, ad eccezione, come visto sopra, della Germania e dei Paesi Bassi, in cui l’intervento è relativamente meno incisivo rispetto alla più alta inflazione energetica.
Infine, segnaliamo che i dati sul commercio estero rilasciati venerdì dall’Istat mostrano un allentamento della pressione della bolletta energetica a seguito del calo di domanda e della minore crescita dei prezzi all’importazione: ad ottobre 2022 il valore delle importazioni di energia segna un aumento del 57,5%, in decelerazione rispetto al +145,1% di settembre, risultato di un dimezzamento dell’aumento dei prezzi (67,1% rispetto al +144,1% a settembre) e di una riduzione del 5,8% dei volumi importati (+0,4%a settembre).
Interventi governativi per proteggere famiglie e imprese dalla crisi energetica nei maggiori paesi Ue e inflazione energetica
Inflazione energetica media 11 mesi 2022, interventi tra settembre 2021 e novembre 2022: aggiornamento al 29 novembre 2022 - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat e Bruegel
Inflazione energetica e trend prezzi elettricità gas in Ue 27
Ottobre e novembre 2022, ordine per inflazione Energia - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
STUDI – Nel 2022 +0,9% produzione manifatturiera, traina la Moda (+9,0%), più colpita dalla pandemia
L’analisi dei dati sulla produzione industriale pubblicati ieri dall’Istat evidenza ad ottobre una flessione congiunturale dell’1,0% dell’indice destagionalizzato della produzione manifatturiera, mentre rimane in territorio positivo (+0,9%) l’andamento congiunturale nella media degli ultimi tre mesi.
Più di metà dell’occupazione del made in Italy in micro e piccole imprese – Nel comparto manifatturiero sono attive 356.873 micro e piccole imprese (MPI) che danno lavoro a 1.897.189 addetti, pari al 51,2% dell’occupazione totale del settore. Alta vocazione artigiana nella produzione del made in Italy, con 229.658 imprese artigiane manifatturiere e 847.029 addetti, quasi la metà (44,6%) dell’occupazione nelle MPI e pari poco meno di un quarto (22,9%) degli addetto totali del comparto.
Il trend tra estate e autunno 2022 - La dinamica positiva nel trimestre agosto-ottobre 2022 è sostenuta dall'andamento positivo di Farmaceutica con +7,0% rispetto il trimestre maggio-luglio 2022, seguita da Farmaceutica con +7,0%, Mezzi trasporto con +3,5%, Computer ed elettronica e Macchinari e impianti, entrambi con +2,5%; segno positivo anche per Gomma, plastica, vetro, cemento, ceramica, con +0,9%, Moda con +0,7% e Altre manifatture, riparazione e installazione macchinari con +0,1%.
2022, l’anno del recupero della moda - In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, nei primi dieci mesi del 2022 la produzione manifatturiera sale dello 0,9% rispetto lo stesso periodo dell'anno precedente e il settore driver è la Moda che registra un aumento di produzione del +9,0%, rimanendo comunque il settore che ha più sofferto gli effetti recessivi della pandemia, con la produzione del 2022 che rimane ancora inferiore del 14,9% al livello del 2019. Crescita della produzione nel 2022 anche per Farmaceutica con +8,7%, Raffinazione petrolio con +8,4%, Computer ed elettronica con +7,4%, Macchinari e impianti con +2,7%, Alimentare e bevande con +2,1%, Mezzi trasporto con +1,5% e Altre manifatture, riparazione e installazione macchinari con +1,0%. Più incerto il trend del Legno, carta e stampa (-0,3%), mentre sono in territorio negativo Apparecchiature elettriche con -2,6%, Chimica con -2,7%, Metallurgia e metalli con -4,3% e Gomme, plastica, vetro, cemento, ceramica con -4,4%. Sul calo della produzione in questi ultimi tre comparti energy intensive pesa il forte rincaro dei costi energetici.
Le incertezze del 2023 - Le imprese di produzione del made in Italy si avvicinano al 2023 in un clima di crescente incertezza, come evidenziato nel 22°report dell’Ufficio Studi Confartigianato presentato nei giorni scorsi. La crisi energetica colpisce i settori manifatturieri più energy intensive e proprio in questi settori sale la domanda di credito per poter sostenere gli esborsi per le bollette, con costi dei prestiti crescenti a causa della stretta monetaria operata dalla Bce: nella riunione del Consiglio direttivo di domani, 15 dicembre, è previsto un ulteriore rialzo dei tassi di riferimento, già saliti di 200 punti base da luglio. Sale la difficoltà di accesso al credito delle imprese, con una intensità che non si registrava dalla crisi del debito sovrano del 2011. Gli alti costi di elettricità e gas determinano una forte riduzione della domanda di energia, con una marcata discesa dei consumi industriali di gas. Una divaricazione dell'inflazione energetica pone un serio problema di competitività delle imprese esposte alla concorrenza internazionale. Inoltre, la manifattura tedesca beneficia di interventi statali contro il caro energia di 2,2 punti di PIL superiori a quelli dell’Italia.
Il commercio internazionale rallenta e nei primi nove mesi del 2022 ristagna l’andamento dell’export in volume, inferiore al punto percentuale, tendenza che ha beneficiato del forte l'apprezzamento del dollaro, ma da fine settembre il trend del cambio si è invertito. Pesa la frenata dell’economia cinese: i macchinari, che risultano i prodotti italiani più venduti in Cina, nei primi nove mesi del 2022 segnano un calo tendenziale delle vendite del 15,4%.
Sul buon andamento del mercato del lavoro contribuisce la manifattura, che nel terzo trimestre del 2022 registra un aumento tendenziale degli occupati dell’1,5%, ma persiste la difficoltà di reperimento della manodopera, che a dicembre 2022 è rilevata per il 52,0% delle assunzioni di operai specializzati e conduttori di impianti e macchine. E’ in attenuazione, nel secondo e terzo trimestre dell’anno, l’effetto negativo sulla produzione della scarsità di materie prime.
Dinamica tendenziale produzione nel 2022 per settore
Gennaio-ottobre 2022, var. % tendenziale, dati corretti per il calendario - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Dinamica congiunturale produzione nel trimestre agosto-ottobre 2022 per settore
agosto-ottobre 2022, var. % maggio-luglio 2022, dati destagionalizzati - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Difficoltà reperimento: totale entrate e dettaglio operai specializzati e conduttori di impianti
Dicembre del 2021 e del 2022 (decrescente), % sul totale entrate - Elaborazione Ufficio Studi