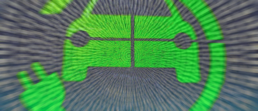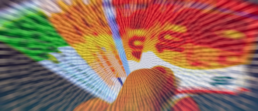TURISMO - Affitti brevi turistici e il loro impatto sull'ecosistema urbano: una riflessione necessaria. Il webinar di Confartigianato
Il 12 luglio scorso, Confartigianato Imprese ha organizzato un webinar dal titolo: "Gli affitti brevi turistici e il loro impatto sull’ecosistema dell’abitare: quale modello di sviluppo turistico per città a misura di imprese, turisti e residenti". L'aumento delle locazioni turistiche di appartamenti sta avendo un impatto significativo sugli ecosistemi turistici delle città italiane, portando a una serie di nuove problematiche che coinvolgono sia i professionisti della ricettività che le attività artigiane.
Il cambiamento nell'ecosistema dell'abitare: L'avvento di numerosi siti specializzati ha favorito crescita degli affitti a breve termine e all'aumento delle presenze turistiche, ma ha anche determinato una competizione sleale che colpisce gli operatori professionali del settore ricettivo, un impatto negativo sul tessuto imprenditoriale e una diminuzione delle attività artigiane nei centri storici, che a contribuiscono in modo significativo alla vitalità e alla vivibilità delle città.
Interventi governativi e normative europee: Per affrontare questa problematica, il Governo ha proposto una bozza di legge sul tema e l'Unione Europea si appresta a varare un regolamento che prevede l'attribuzione di un codice di riconoscimento ad ogni locazione. Queste misure mirano a quantificare e regolamentare il fenomeno degli affitti brevi turistici.
Una riflessione necessaria: Il webinar promosso da Confartigianato Imprese, aperto a tutti, offre un'opportunità di riflessione su questo fenomeno evidenziando le ripercussioni non solo sui residenti, ma anche sull'intero tessuto imprenditoriale e, in particolare, sulle attività artigiane. Si tratta di una discussione importante per trovare un equilibrio tra lo sviluppo turistico e la tutela delle attività imprenditoriali locali, contribuendo a creare una città a misura di imprese, turisti e residenti. Il webinar vuole dunque offrire una riflessione su questo fenomeno, coinvolgendo tutti gli attori interessati (al webinar interveranno tra gli altri Filippo Celata, Ordinario di Geografia economica all’Università La Sapienza di Roma, Antonio Preiti, Economista e docente presso l’Università di Firenze, Roberto Cozzani, Presidente Consorzio degli affittacamere “Welcome to La Spezia” di Confartigianato La Spezia) al fine di individuare soluzioni che favoriscano un modello di sviluppo turistico sostenibile e armonioso, capace di preservare l'identità delle città e il loro patrimonio artigianale.
Scarica il programma del webinar
STUDI - Tornano a salire gli investimenti pubblici: +15,4% nel primo trimestre 2023. La spinta del PNRR nel prossimo triennio
Nel primo trimestre del 2023 l’economia italiana è caratterizzata da una crescita del PIL dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, mentre in Germania ed Eurozona si conclama una recessione tecnica. Per tasso di crescita nel primo trimestre dell’anno, l’Italia è al 6° posto in Ue e il dinamismo dell'economia italiana sopravanza quella spagnola (+0,5%) e francese (+0,2%), mentre quella tedesca è in recessione, segnando il secondo arretramento consecutivo (-0,3% dopo -0,5% del quarto trimestre 2022).
Al sostegno dei processi di crescita tornano a contribuire gli investimenti pubblici, dopo un anno, il 2022, in cui il loro valore era sceso dell’1,1%. L’ analisi del conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche pubblicato questa settimana dall’Istat evidenzia che nel primo trimestre del 2023 gli investimenti della Pubblica amministrazione (Pa) salgono del 15,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il segnale di crescita di inizio anno conferma le previsioni del DEF 2023 dello scorso aprile secondo le quali i processi di accumulazione di capitale pubblico dovrebbero registrare un biennio di marcata crescita: gli investimenti pubblici in rapporto al PIL, che erano al 2,9% nel 2021 e sono scesi al 1,7% nel 2022, dovrebbero risalire al 3,3% nel 2023 per raggiungere il picco del 3,8% nel 2024, superando il precedente massimo storico del 3,7% registrato nel 2009.
La crescita degli investimenti è spinta dagli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nell'analisi della Corte dei conti proposta nel Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, gli investimenti pubblici assorbono il 63% della spesa prevista dal Piano e nel DEF 2023 si stima che l’impatto del PNRR sugli investimenti totali dell’economia italiana sia del 8,0% in più rispetto allo scenario base nel 2023, del +11,0% nel 2024, del +13,0% nel 2025 e del +12,4% nel 2026.
Su questo fronte è essenziale mantenere i programmi di spesa del PNRR e contrastare le diffuse difficoltà burocratiche e gestionali. L’analisi sugli interventi ce presentano elementi di debolezza svolta nella Terza Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR presentata dal Governo individua 59 progetti di investimento del Piano con difficoltà normative, amministrative, gestionali, ecc. e 44 misure di investimento che prevedono una ridefinizione delle decisione di esecuzione del Consiglio e delle disposizioni operative che stabiliscono milestone e target, a seguito di errori, rimodulazione target, indicatori per rendicontazione, ecc…
Gli investimenti pubblici sono strategici per combattere le conseguenze del cambiamento climatico e la recente esperienza dell'alluvione in Emilia Romagna ha evidenziato che la caduta della spesa per interventi contro il rischio idrogeologico espone cittadini e imprese alle conseguenze devastanti dei fenomeni climatici estremi. Nel corso della recente audizione in Commissione ambiente alla Camera sul decreto alluvioni, Confartigianato ha indicato che tra il 2008 e il 2020 le risorse pubbliche destinate all’ambiente hanno cumulato un calo di 42,7 miliardi di euro.
Le evidenze su investimenti della Pa e sulle tendenze della finanza pubblica sono contenute nel 25° report di Confartigianato ‘Intelligenza artificiale, lavoro e imprese'. Qui per scaricarlo.
Trend investimenti pubblici
I trim. 2010-I trim. 2023, var. % tendenziale, dati grezzi - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Investimenti pubblici in rapporto al PIL
2001-2022, 2023-2026 quadro tendenziale DEF 2023, % PIL - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Mef
STUDI – Piccole imprese e sostenibilità: i key data nel Bilancio sociale di Confartigianato
Il contributo di Confartigianato alla transizione sostenibile delle piccole imprese è delineato nel bilancio sociale pubblicato nei giorni scorsi, che esamina il ruolo della confederazione nell’economia e nella società del Paese nell’anno della guerra in Ucraina, della crisi energetica e delle materie prime. Nel focus sulla sostenibilità l’Ufficio Studi propone alcune evidenze che tratteggiano l’orientamento alla sostenibilità delle micro e piccole imprese ad alta vocazione artigiana.
L’alternarsi nell’arco di un ventennio di dieci differenti e gravi crisi - terroristica, finanziaria, debiti sovrani europei, sanitaria, delle catene globali del valore e delle commodities, energetica, russo-ucraina, demografica e climatica - richiede un cambio di paradigma nel modello di sviluppo, sempre più orientato ad una crescita sostenibile.
Il sistema imprenditoriale italiano, caratterizzato da una diffusa presenza di micro e piccole imprese (MPI), presenta alcuni caratteri strutturali di orientamento alla sostenibilità. Grazie ad una matrice tecnologica specializzata nella manifattura leggera, caratterizzata da una minore intensità di energia, l’economia italiana presenta un minore impatto di emissioni climalteranti. L’esplosione della crisi energetica dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha accelerato la riduzione dei consumi di energia e l’aumento dell’efficienza energetica da parte delle imprese, mentre sale la domanda di competenze green dei lavoratori. La ripresa post-pandemia è stata sostenuta dalla creazione di valore aggiunto nelle costruzioni, settore dominato dalle micro e piccole imprese, con interventi sul patrimonio abitativo finalizzati al risparmio energetico, associati ad incrementi della produttività del lavoro. L’Italia presenta un peso dell’economia circolare più elevato degli altri maggiori paesi europei, grazie all’apporto di un articolato sistema di micro e piccole imprese operanti nella riparazione, riciclo e riuso. Per una mobilità sostenibile le imprese dell’autoriparazione - settore più rilevante della circular economy e con una elevata vocazione artigiana - offrono servizi sul mercato delle auto ibride ed elettriche, mentre è attivo un cluster di imprese della manifattura e dei servizi nella filiera della bicicletta.
Una elevata presenza di MPI caratterizza l’offerta di prodotti alimentari di qualità, che contribuiscono alla sicurezza alimentare e migliorano la nutrizione. La rielaborazione delle materie prime legate al territorio promuove la domanda di prodotti a ‘chilometro zero’ e un’agricoltura sostenibile.
La crescente presenza di imprenditori e lavoratori indipendenti laureati e il reticolo di relazioni tra imprese, studenti e scuole rafforza la qualità dell’istruzione. L’Italia è leader in Europa per imprenditrici e lavoratrici autonome e una diffusa presenza sul territorio dell’imprenditoria femminile favorisce il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e la partecipazione al mercato del lavoro delle donne. La caduta dell’occupazione indipendente conseguente alla pandemia e alla crisi energetica è stata meno accentuata per la componente femminile.
Una maggiore diffusione dell’apprendistato agevola l’ingresso dei giovani sul mercato del lavoro e riduce il ritardo dell’Italia, misurato da un più basso tasso di occupazione giovanile. Nelle MPI la domanda di lavoro è maggiormente orientata all’utilizzo di lavoro stabile, a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato caratterizzato ad un elevato tasso di trasformazione.
Il maggiore dinamismo della spesa in R&S delle micro e piccole imprese sostiene l’innovazione tecnologica e la competitività del made in Italy.
L’artigianato e le MPI rappresentano fattori chiave di coesione economica e sociale, con una maggiore presenza nel Mezzogiorno e nei piccoli comuni. L’insediamento diffuso delle MPI e delle imprese artigiane attenua il trend di declino delle aree interne e di montagna. Le MPI sono un terreno più fertile per il capitale umano giovane e femminile. La micro impresa rappresenta in ambito sociale un importante luogo di integrazione per gli stranieri che trovano impiego molto più frequentemente in imprese di piccole dimensioni dove è inferiore la discriminazione.
PIccole imprese e sostenibilità
(Numeri chiave - Elaborazione Ufficio studi Confartigianato)
STUDI – A 10 anni dal recepimento della direttiva sui tempi di pagamento 1.225 comuni pagano in grave ritardo, oltre 60 giorni
I tassi di interesse sono in salita e il costo del credito pesa sui bilanci aziendali. Per una gestione ordinata della liquidità d’impresa è determinante la congruità dei tempi di pagamento delle forniture. Secondo i dati dell’European Payment Report 2023 di Intrum nell’area dei pagamenti tra imprese (B2B) in Italia si registra un tempo effettivo di pagamento di 56 giorni, in linea con la media europea.
Le prospettive per il sistema delle imprese che si delineano con la revisione della Direttiva europea contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita in Italia nel 2013, sarà al centro della conferenza organizzata da Confartigianato con Pimec (l’Associazione che rappresenta le micro, piccole e medie imprese della Catalogna) e la Piattaforma contro i ritardi di pagamento spagnola che si terrà lunedì prossimo 3 luglio a Bruxelles, presso il Comitato economico e sociale europeo, aperta dal Presidente di Confartigianato Marco Granelli e in cui interverrà, tra gli altri, Bruno Panieri, Direttore delle Politiche Economiche. Qui per il programma.
Sul fronte delle forniture alla Pubblica amministrazione (Pa), l’Italia presenta il più alto peso sull’economia dei debiti commerciali della Pa verso le imprese. Il confronto europeo, condotto sui dati relativi alla sola parte di spesa corrente comprensiva delle anticipazioni, evidenzia che il debito commerciale della Amministrazioni pubbliche in Italia è pari al 2,6% del PIL nel 2022. Si tratta dell'incidenza più alta in Ue davanti alla Finlandia (2,2%) e al Lussemburgo (2,0%) e che supera nettamente l’1,6% della media Ue a 27 e della Germania, l’1,5% Francia e lo 0,8% della Spagna.
Secondo il monitoraggio del MEF, nel 2022 sono state registrate 29,7 milioni di fatture ricevute dalle Pubbliche amministrazioni, per un importo totale di 179 miliardi di euro, con tempi medi di pagamento da parte delle Pa di 39 giorni.
I tempi di pagamento dei Comuni - Sul fronte dei Comuni, il tempo medio di pagamento è di 36 giorni. La situazione è differenziata sul territorio: si va dai 24 giorni dei comuni del Nord Est, ai 26 giorni del Nord Ovest, per salire ai 36 giorni del Centro, ai 46 giorni delle Isole e i 52 giorni del Sud.
In relazione alla regione di appartenenza delle amministrazioni comunali, si riscontrano tempi più elevati e superiori alla media per i comuni di Calabria e Campania con una media di 62 giorni, seguite da quelli di Sicilia con 54 giorni, Lazio con 51 giorni, Abruzzo e Molise con 47 giorni e Basilicata con 46 giorni. Valori attorno alle media per i comuni di Puglia e Umbria con 36 giorni, Marche con 34 giorni e Piemonte con 31. Nella media regionale, sono in linea con la normativa in vigore, i comuni di Emilia-Romagna con 28 giorni, Liguria, Sardegna e Toscana con 27 giorni, Lombardia con 24 giorni, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta con 22 giorni e Veneto con 21 giorni.
I Comuni in maggiore ritardo - A 10 anni dal recepimento sulla direttiva sui pagamenti, vi sono 1.225 comuni che, su un totale di 5,5 miliardi di euro di fatture di acquisto di beni e servizi, pagano le imprese oltre i 60 giorni, con un tempo medio di pagamento di 84 giorni. Vi sono poi altri 1.275 comuni, per altri 5,8 miliardi di euro di acquisti, che pagano con apprezzabile ritardo tra 41 e 60 giorni, con un tempo medio di pagamento di 49 giorni. Per 1.263 comuni il ritardo rispetto i termini di legge e più contenuto, tra 31 e 40 giorni, con una media di 35 giorni, mentre sono 4.112 i comuni in regola con la normativa, che pagano entro 30 giorni, con una media di 21 giorni.
Debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche per beni e servizi nei paesi dell'Ue
Anno 2022. % PIL, spesa parte corrente incluse anticipazioni - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea
Tempi di pagamento dei Comuni per regione di appartenenza del comune
Anno 2022, tempi di pagamento medi - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Mef